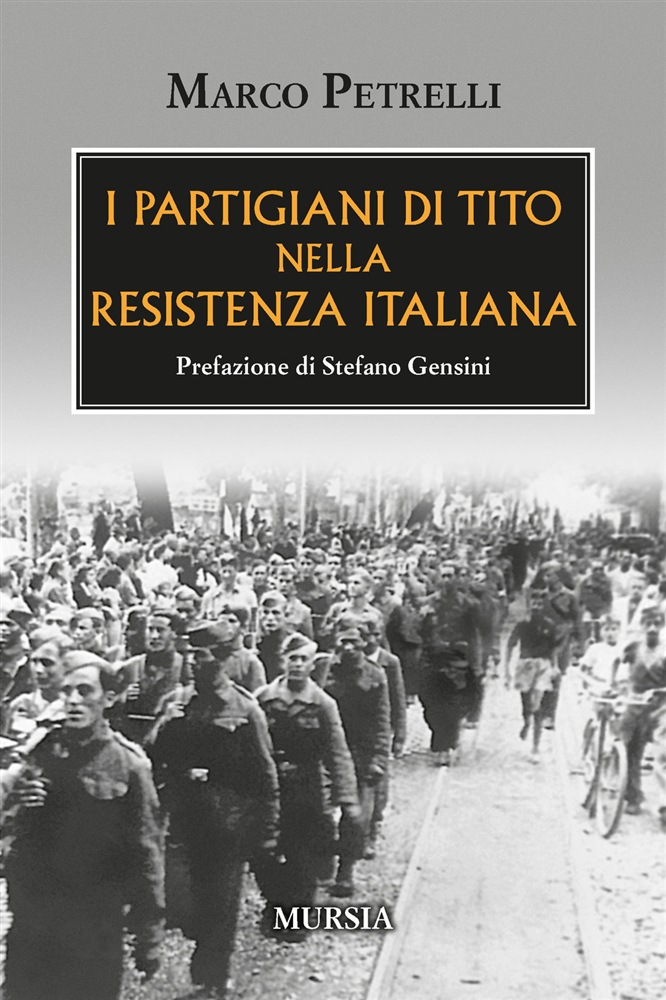Intervista a Marco Petrelli, autore del libro “I partigiani di Tito nella Resistenza italiana”
L’8 maggio ricorreva il 77esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. In vista di questa data, abbiamo intervistato Marco Petrelli, autore del libro “I partigiani di Tito nella Resistenza italiana”.
Il giornalista ha spiegato qual è stato il ruolo degli jugoslavi nella Resistenza, realizzando un’attenta analisi storica della figura di Tito e del suo progetto politico durante e dopo la Seconda guerra mondiale.
Nel libro si parla del Campo di Ferramonti di Tarsia, il più grande campo di internamento italiano, il quale si estendeva su un’area di 16 ettari e contava circa 92 baracche di varie dimensioni. Fu il primo campo di concentramento ad essere liberato durante la II guerra mondiale. Dopo la liberazione, rimase aperto come campo a conduzione ebraica e, al termine della guerra, fu chiuso.
Come nasce l’idea del libro?
Alcuni anni fa, mi sono occupato della vicenda di un sindacalista locale: Maceo Carloni, attivo alle Acciaierie di Terni prima e durante la Seconda guerra mondiale, ucciso da formazioni partigiane comuniste del ternano nel 1944. Il movente dell’esecuzione (un vero massacro) fu sopprimere una spia fascista, che Carloni non era. I partigiani ternani, operativi nei primi mesi del ’44, ebbero nel loro organico diversi slavi, inquadrati nei Battaglioni Tito 1 e Tito 2. Da quella vicenda, un percorso di studio a ritroso fino all’aprile del 1941, quando le forze dell’Asse invasero il Regno di Jugoslavia e molti jugoslavi finirono prigionieri in Italia, dall’Umbria alla Calabria. E non solo. Si presentava l’opportunità di analizzare un capitolo di storia nazionale che si intrecciava alle vicende balcaniche sotto il profilo storico, antropologico e culturale.
Quali sono le fonti su cui hai lavorato?
Fondamentale è stato l’apporto di Enrico Carloni, figlio del sindacalista Maceo, instancabile ricercatore che, per difendere la memoria del padre, ha raccolto una mole di documenti all’Archivio Centrale dello Stato, reperendo altresì sentenze di processi, denunce, verbali d’interrogatori e costruendo una voluminosa bibliografia. Materiale, indicazioni, consigli che ha voluto condividere con me. Importanti sono stati anche i rapporti dell’Office Strategic Service statunitense e, dopo il 1947, della CIA con dettagliate analisi sulla situazione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Poi, le ricerche all’Ufficio Storico dell’Esercito e all’Archivio Storico della Camera dei Deputati, compreso il famigerato “Armadio della Vergogna” sui crimini di guerra nazisti. Un viaggio entusiasmante!
Hai definito il comunismo come un “collante” sociale, evidenziando che a contribuire all’ascesa militare e politica di Tito fu il nazionalismo. Dico bene?
Esattamente. In Occidente abbiamo l’abitudine di analizzare il mondo con l’ottica dell’ideologia eppure, il resto del mondo quell’ottica la rifiuta. Ovvero, i popoli in cerca di un loro spazio e desiderosi di essere nazione hanno sfruttato l’ideologia come viatico per raggiungere il loro obiettivo. L’espulsione della Jugoslavia dal Cominform, l’apertura di Belgrado agli Stati Uniti ed alla Gran Bretagna, la posizione cosiddetta “non allineata” assunta da Tito mostra come il leader jugoslavo alla fine degli Anni ’40 avesse piegato l’ortodossia comunista alla ragion di stato.
Perché parlare di foibe e di esodo provoca spesso una reazione da parte di alcuni settori della politica, dell’associazionismo e del mondo della cultura ritenendo che possa trattarsi di un attacco alla Resistenza?
Perché la società italiana subisce, da oltre mezzo secolo, una radicale infiltrazione della politica in ogni suo angolo, dall’economia alle relazioni internazionali, dall’arte all’educazione. La Resistenza è forse l’icona di questa perniciosa influenza: si chiamavano patrioti, si è deciso di chiamarli partigiani; il loro inno era Il Piave, si è imposta Bella ciao che oltretutto è post bellica. Era formata da militari, civili di orientamento liberale, cattolico, riformista, apolitico… e da comunisti. E si è deciso avesse un unico orientamento. Ogni tentativo di analizzarla, di contestarne zone d’ombra (Porzus, Codevigo, Schio) o silenzi ingiustificati (foibe, esodo, penetrazione slava in Friuli) ha inoltre generato una levata di scudi. Da movimento di liberazione a totem della ricerca storica… Se importante fu il ruolo dei partigiani nella Campagna d’Italia, non fu determinante alla vittoria anglo-americana. Ed è altrettanto vero è che gli Alleati, talvolta, ne diffidassero anche nel timore che, al tavolo della pace, l’Italia potesse rivendicare qualcosa. Eravamo stati sconfitti e da sconfitti siamo stati trattati.
Nel libro, hai parlato del campo di Ferramonti di Tarsia. Cosa è emerso dalle tue ricerche?
L’Italia si affacciò alla Seconda guerra mondiale con grande impreparazione dal punto di vista del concentramento dei futuri prigionieri di guerra e per l’internamento civile, forse perché a Roma si riteneva la vittoria tedesca imminente. Alcuni campi furono ricavati da ex campi di prigionia per gli austro-ungarici, altri da conventi, tenute riconvertite o realizzati ex novo, come Ferramonti di Tarsia, inaugurato nel 1940 e destinato a civili ebrei italiani e stranieri, a prigionieri di guerra ed a civili di paesi nemici, fra questi anche cinesi che lavoravano in Italia.
Quali erano le condizioni dei prigionieri?
Per quanto dure per la carenza di cibo e per la situazione logistica, le condizioni erano molto diverse da quelle dei lager nazisti: sembra che, a Ferramonti, dei 2000 prigionieri dal 1940 al 1943 ne morirono 4 colpiti da un aereo alleato. Il primo direttore del campo, Paolo Salvatore, permetteva agli internati di uscire dal campo per lavorare e per integrare le razioni alimentari. Mesi dopo, fu rimosso perché considerato troppo permissivo. I prigionieri ebrei erano assistiti dalla Delegazione per l’Assistenza degli Emigranti Ebrei, struttura nata con il placito del regime fascista nel 1939.
Qualche aneddoto sul campo di Tarsia?
Fra gli internati celebri Alfred Wiesner, ingegnere jugoslavo e poi partigiano che a fine guerra fondo un’azienda di gelati. Con i suoi soci pensarono di chiamarla: ALGIDA. Il secondo: nel 1994, la regista Gabriella Gabrielli realizzò un film su Ferramonti, “18 000 giorni fa” che si apriva con un’intervista a Simon Wiesenthal il quale esprimeva un’importante considerazione sull’antisemitismo in Italia e su quello, coevo, nella Germania nazista.
Intervista di Denise Ubbriaco a Marco Petrelli
Fonte: Quotidiano del Sud – 09/05/2022
*