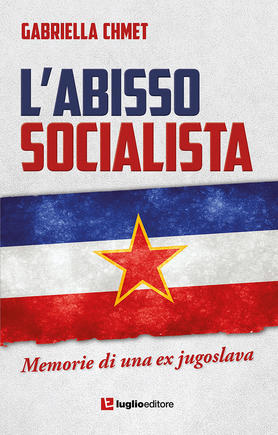Il libro di Gabriella Chmet (Luglio editore) racconta una ragazzina degli anni ’80 in una frazione di Portole quando il regime del Maresciallo imponeva l’utopia di una società fintamente integrata
Della vita quotidiana al tempo della Jugoslavia di Tito si sa poco. Il vero volto del Paese è rimasto nascosto dietro il credito acquisito dopo la rottura con l’Urss, che per le cancellerie occidentali aveva fatto dello stato balcanico un interlocutore da trattare con un occhio di riguardo. Mentre Tito a Brioni riceveva i vip di mezzo mondo, la Jugoslavia viveva in un regime totalitario: la prigione per una frase sbagliata, l’ossessione precoce dell’indottrinamento politico, la delazione incoraggiata e premiata tra vicini di casa, la costante sorveglianza della polizia politica. E poi c’era il fallimento economico, una società a due facce, una ricca burocrazia e una classe operaia sempre più povera. Di tutto questo si è parlato poco perché dopo la fine della Jugoslavia è arrivata subito la guerra a spazzare via il passato e imporre nuove priorità. Ora il libro di Gabriella Chmet, autrice e blogger che da diversi anni racconta presente e passato di un piccolo mondo di confine, apre le porte di quello che è stato ‘L’abisso socialista’ (Luglio editore, 150 pagg., 12 euro) e ci racconta come andavano le cose dall’altra parte. Un racconto della vita quotidiana ai tempi di Tito visto da una ragazzina degli anni Ottanta (Chmet è nata nel 1973) cresciuta a Stridone, frazione di Portole.
La guerra in Jugoslavia ha fatto dimenticare com’era il Paese prima, i lunghi anni di Tito al potere.
«È vero, e un po’ è colpa anche nostra – risponde Chmet -. Io ho aspettato trent’anni prima di scrivere questo libro. L’occidente come faceva a conoscere lo stile di vita del socialismo reale visto che non ne abbiamo mai parlato neanche noi? C’era una specie di paura recondita, ci avevano inculcato il terrore, ci avevano indottrinato in un modo che a molte persone impedisce di parlare ancora oggi. Ho molti amici e parenti in Istria e questa difficoltà a raccontare, questo abbassare gli occhi quando si entra in argomento è ancora molto radicato. A distanza di trent’anni non abbiamo superato un trauma psicologico».
Nel libro lei racconta di come fosse diffusa la pratica della delazione, al punto che si continuava a vivere accanto a persone che ti avevano denunciato.
«Fare la spia, anche tra vicini di casa, era una pratica generalizzata anche dopo la morte di Tito. Nel libro racconto un episodio, che ho appreso tre anni fa, capitato alla fine degli anni Settanta a un giovane che era andato in Istria a trovare dei parenti. Durante la cena, cui partecipavano anche dei vicini, si era lasciato sfuggire che aveva portato dell’olio perché in Jugoslavia non si trovava. Al ritorno in Italia era stato fermato al confine, portato a Capodistria per accertamenti e lasciato in carcere per dieci giorni senza spiegazioni. Durante il suo ‘soggiorno’ in prigione l’unica cosa che gli avevano dato era mezzo bicchiere d’olio due volte al giorno, accompagnato dalla frase “vedi che in Jugoslavia non manca l’olio?”».
Come vivevate dal di dentro un paese composito come la Jugoslavia?
«Ti raccontavano la favola di popoli di religioni e lingue diverse che vivevano insieme in armonia grazie alla guida del maresciallo Tito. Non era così perché la gente ha continuato a mantenere le proprie tradizioni, l’identificazione non è mai scattata. Mi è capitato di conoscere serbi, croati, sloveni, bosniaci e la sensazione era che si faceva finta. C’era il mito fondativo di Tito, per cui intellettuali e poeti non scrivevano altro, rappresentavano una realtà che non esisteva. L’autogestione e il ruolo della Jugoslavia nei paesi non allineati erano due mantra. I giornali parlavano per mesi dei summit dei non allineati».
Da un po’ di tempo si sente parlare di Jugonostalgia, e sono ricomparse le scritte ‘Tito’ anche in Slovenia, come lo spiega?
«I Balcani sono anche questo, tutto e il contrario di tutto. Gli sloveni sono stati i primi a chiedere di staccarsi dalla Jugoslavia, quando era ancora vivo Tito, eppure a distanza di decenni qualcuno dice si stava meglio quando si stava peggio. Il motivo è che il presente ha deluso e si guarda indietro. Il mito di Tito è rinato anche in Croazia, dove i monumenti alla patria jugoslava che erano un po’ andati in rovina negli ultimi anni sono stati tirati a lucido. Una parte della popolazione ricorda i privilegi che ha perduto, penso alla burocrazia e al ceto politico, e poi c’erano scuola e sanità garantite».
I suoi genitori erano iscritti al registro degli italiani. Si sentivano ed erano isolati.
«Soprattutto perché non avevano aderito alle comunità degli italiani. Questi organismi si erano dovuti adeguare alla narrazione titoista. Così come i giornalisti, penso a ‘La voce del popolo’ o a Radio Tv Capodistria, che collaboravano col regime. Inoltre, pur essendo degli antifascisti – un prozio ha rischiato la vita durante il fascismo perché aveva fondato clandestinamente il partito repubblicano – nessuno della mia famiglia aveva collaborato con i partigiani. Questo era, per così dire, il peccato originale».
Gli anni della scuola sono stati un calvario, botte dai maestri, umiliazioni in quanto italiana.
«Se fossi cresciuta a Buie o a Umago avrei avuto accesso alle scuole italiane, dove gli insegnanti non erano violenti. Ma essendo cresciuta in un luogo isolato come Stridone ho dovuto fare la scuola dell’obbligo in lingua croata, con insegnanti che venivano da posti molto lontani, con una cultura completamente differente. Ho ancora gli incubi di quel periodo».
Intervista di Paolo Marcolin – 15/06/2021
Fonte: Il Piccolo
Gabriella Chmet, L’abisso socialista. Memorie di una ex jugoslava, Luglio, Trieste 2021.